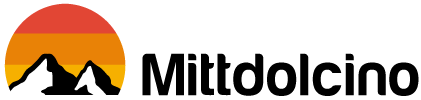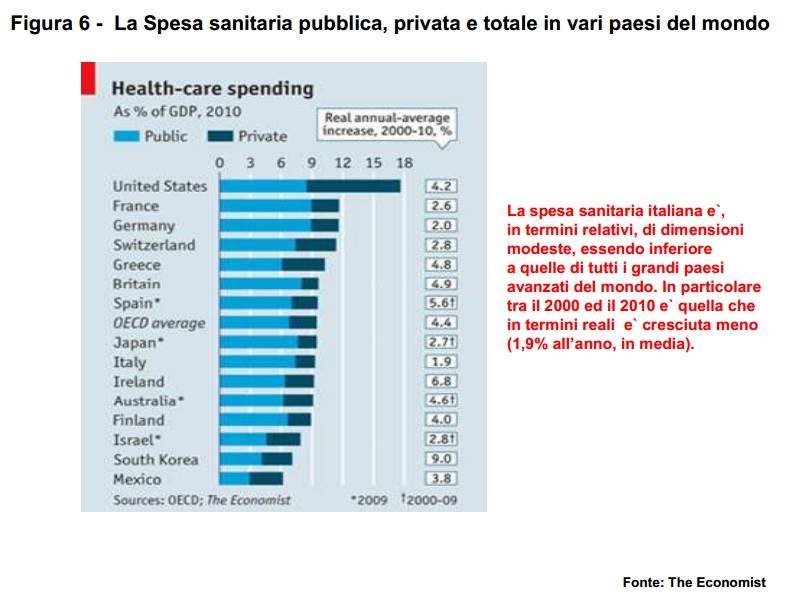Mary Wakefield per The Spectator
La cosa più coraggiosa che abbia mai visto è stata la decisione di Albert, 93 anni, di morire. Nei giorni successivi cominciò ad allontanarsi dalla propria coscienza, come un nuotatore che si gira e si tuffa nel buio.
Albert non era religioso. Sto scrivendo quest’articolo perché da un decennio sono diventata cattolica e solo dopo la sua ultima settimana di vita, nella Primavera dello scorso anno, ho cominciato a capire cosa siano la Pasqua e la Passione di Cristo.
Incontrai Albert per la prima volta quando il destino decise di chiamare il mio bluff. Per anni avevo annoiato mio marito sulla necessità di una strategia per mettere in contatto le persone con i loro vicini anziani.
Poi, una sera, in un ristorante del nord di Londra trovai sul tavolo il volantino di una società che pubblicizzava proprio questo: la Befriending Network.
Quando il giorno dopo telefonai mi misero in contatto con un’associazione benefica ancora più locale – la Dorcas – e, in pochi giorni, fui abbinata ad Albert, nessun figlio e moglie deceduta, impegnandomi a visitarlo una volta alla settimana.
Se solo le grandi organizzazioni di beneficenza fossero così agili!
Il nostro primo incontro fu a dir poco infausto. Fui accompagnata dalla coordinatrice, Laura, una bella e gioiosa trentenne che si era registrata per Albert la settimana prima.
Albert si appoggiò allo schienale della sua poltrona di cuoio, antico e imperscrutabile, ma era chiaro che si sentiva vittima di una specie di trappola.
Il nostro secondo appuntamento, senza accompagnatrice, non andò molto meglio. Albert era molto sordo, sia a livello fisiologico che, occasionalmente, per scelta. Sedetti di fronte a lui e affrontai le sue domande soffocanti, piatte, sudate e urlanti.
“Allora, Albert, ti raccolgo i tubetti del colore?”
“Prego?”
“Ma tu dipingi, Albert?”
“Mi dispiace …”, rispose, facendo un gesto verso il suo orecchio e scuotendo tristemente la testa.
Quando giunse l’ora di andarmene mi disse con gentilezza: “Ascoltami, tutto questo è un’idea di mio nipote. Non ho bisogno di nessuno che tu conosca. Non sono solo”.
Settimana dopo settimana i nostri rapporti cominciarono a migliorare. Albert mi raccontò del suo lavoro come operatore radiofonico durante la guerra e di una ragazza che amava, anche se non l’incontrò mai, conosciuta solo grazie al segnale radio.
Mi mostrò i suoi dipinti e io gli mostrai i miei e, dalla Primavera del 2017, diventammo amici.
Io non avevo mai conosciuto né i miei nonni né, prima d’ora, degli ultranovantenni. Questa vicenda, quindi, è stata per me sia un corso di formazione che una storia di grande amicizia – un corso intensivo su cosa c’è in serbo per tutti noi.
Albert era sempre ben tirato, ma un giorno gli sfuggì che gli ci volevano quattro ore per vestirsi. Un’ora solo per i calzini, disse, per la difficoltà di raggiungere i piedi.
Gli infermieri venivano un paio di volte a settimana ma erano quasi sempre frettolosi e occasionalmente anche maleducati. A volte, disse Albert, si presentavano senza preavviso e cominciavano a sbottonargli la camicia senza nemmeno dirgli una parola. Ma questo è normale?
Se si addormentava a metà conversazione sedevo e guardavo il suo appartamento. C’era una serie di acquerelli delle grandi Cattedrali britanniche e, tutt’intorno alla stanza, una linea dorata dipinta a mano all’altezza del punto-vita.
Nell’Inverno del 2017 Albert cadde. Era ovvio che sarebbe successo, era solo una questione di quando e di chi lo avrebbe trovato. Arrivai un giorno alla sua porta d’ingresso e, dopo aver bussato, non sentii il solito strascicare dei piedi ma solo un debole grido. Era sdraiato sul pavimento della sua camera da letto.
Era stato lì tutto il giorno ma, quando cercai di sollevarlo, non ne fui capace. Scrissi un pezzo, una volta, criticando i medici che non sollevano i pazienti per paura di farsi male alla schiena. Ora mi dispiace di averlo scritto. Persino un corpo da uccello come quello di Albert pesava una tonnellata.
Ma in qualche modo, facendo una sorta di danza, folle e lenta, raggiungemmo la sua poltrona dove cominciò un’attesa di sette ore prima di ricevere aiuto.
Aspettammo tutto il pomeriggio e fino a tarda sera. Cominciai a chiamare il 999 ad ogni ora, chiedendo informazioni sulla nostra ambulanza fino a quando un operatore ci disse la verità: “Non c’è nessuna ambulanza in arrivo. Siamo troppo occupati. La vostra richiesta continua ad essere spostata in coda”.
Albert mi disse: “Non posso farcela. Non riesco a sopportare tutto questo”. Fuori era buio e pioveva. Ricordo di aver guardato Albert, coperto di sangue e vestito a metà, pensando a quanto fosse dignitoso compatibilmente con la situazione.
Albert trascorse un mese in ospedale, passando dal Reparto di Riabilitazione al Pronto Soccorso per le continue infezioni. Il suo letto era costituito da un materasso sul pavimento perché – così disse la suora del reparto – continuava a cadere.
“Non è che cado”, disse Albert, “è solo che quando mi sveglio nel bel mezzo della notte non so se sto sdraiato o in piedi. È una sensazione veramente strana”. Ricordo di aver pensato che l’anima di Albert stesse cercando di lasciare il suo corpo ma, prima d’ora, non avevo mai condiviso con nessuno questo pensiero.
Fino a quel momento il futuro di Albert era stato nelle mani dello staff dell’ospedale. “Stanno avendo un incontro su di me”, mi diceva quando andavo a visitarlo, con l’aspetto ansioso di un alunno che guarda i genitori.
Ma, a metà Febbraio, assunse di nuovo la responsabilità della sua vita.
“Devo morire”, mi sussurrò con disperata risoluzione, “non c’è altro modo”. Ed io non riuscivo a contraddirlo perché aveva ragione.
Quando rividi Albert, pochi giorni dopo, era già avviato lungo la sua strada. Era irraggiungibile, chiuso in sé stesso ben oltre le parole. “Non mangerà né berrà più”, disse l’infermiera, “e ieri sera ha dato un calcio alla parete dell’ospedale”.
Sembrava impressionata. Ma Albert era ancora lì, in una qualche parte del suo corpo scheletrico perché, quando gli presi la mano, me la strinse forte per diversi minuti. Baciai la sua testa e dissi qualcosa di stupido tipo: “Andrà tutto bene”.
Questo non vuole essere un argomento a favore dell’eutanasia, ma non c’era davvero altro modo per rendere meno dolorosa la parte finale della sua vita. Come Cristo nel giardino dello Getsemani, Albert voleva davvero vivere e spese metà della sua agonia a convincersi che non esisteva un’altra soluzione.
Ho pensato in seguito a tutti gli inutili consigli sulla vita offerti dal XXI° secolo: potete fare tutto ciò che volete, siate voi stessi. Ma a me veniva in mente la Croce che, ci piaccia o meno, dice la verità.
———————–
Link Originale:https://www.spectator.co.uk/2019/04/my-friends-death-taught-me-what-easter-really-means/
Scelto e tradotto da Franco
*****
Le immagini, i tweet, e i filmati pubblicati (i contenuti) nel sito sono tratti da Internet per cui riteniamo, in buona fede, che siano di pubblico dominio e quindi immediatamente utilizzabili. In caso contrario, sarà sufficiente contattarci all’indirizzo info@mittdolcino.com perché vengano immediatamente rimossi. Le opinioni espresse negli articoli rappresentano la volontà e il pensiero degli autori, non necessariamente quelle del sito.