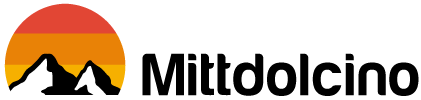Redazione: Nella desolazione del nostro paese — dove un ex Primo Ministro dirige la scuola dei Servizi Segreti d’oltralpe e un ex Sottosegretario agli Affari Europei confonde, nel tricolore, il verde con il blu — un nostro lettore ci ha proposto il racconto di un grande soldato americano, che ci ha colpito per dignità e senso di appartenenza.
Traspare fra le righe quasi un senso di commozione, misto ad orgoglio, per poter ancora servire il suo paese. Il Gen. Jim Mattis mai avrebbe tradito la sua Patria.
Sulle successive dimissioni da Segretario alla Difesa dell’Amministrazione Trump non se ne son dette poi così tante.
Nell’inner circle presidenziale era forse il più “morbido” sui rapporti con gli altri paesi della Nato, ma decisamente il più “duro” sul Medio Oriente e, in particolare, sulla Siria e l’Iran (chissà cosa sarebbe successo con Mattis “secdef”).
Fossimo stati in contatto con il Generale gli avremmo ricordato, d’impulso e con un po’ di cinismo, che oltre agli amici e ai nemici esiste anche la categoria dei “falsi amici”, nello specifico annidati presso la Nato.
Non annoiamo il lettore facendo nomi che già conosce — ma chi mai ci convincerà che quei paesi, oggi, siano “pienamente alleati” degli Stati Uniti?
—————–
Jim Mattis per The Wall Street Journal (estratto)
A fine novembre 2016, mentre passavo la Festa del Ringraziamento nella mia città natale sul fiume Columbia (Stato di Washington), fui raggiunto da un’inattesa telefonata del Vicepresidente Mike Pence: “Incontreresti il Presidente Donald Trump per discutere dell’incarico di Segretario alla Difesa?
Non avevo preso parte alla sua campagna elettorale e non avevo mai incontrato o parlato con il sig. Trump. Dire, quindi, che ne fui sorpreso è un eufemismo.
Sapevo inoltre che, in assenza di una deroga congressuale, la Legge Federale proibiva ad un ex Ufficiale di servire come Segretario alla Difesa per sette anni dalla data del congedo.
Visto che non c’erano precedenti, se non quello del Generale George Marshall, nominato nel 1950 dopo 3 anni e mezzo dal congedo, dubitavo di poter essere il candidato giusto.
Tuttavia, sentivo dentro di me che sarei dovuto andare a Bedminster, nel New Jersey, per quell’incontro.
Meditai a lungo su come esprimere al Presidente la mia visione sul ruolo dell’America nel mondo.
Durante il volo da Denver le informazioni-standard sulla sicurezza, espresse dell’assistente di volo, attirarono la mia attenzione: “ ….. se diminuisce la pressione della cabina le maschere cadranno automaticamente ….. indossate la maschera rapidamente e poi aiutate gli altri attorno a voi …..”.
Quelle parole mi sembrarono una metafora: per preservare il nostro ruolo di leader mondiale dovremmo fare in modo che il nostro Paese, innanzitutto, possa agire unito.
Il giorno successivo fui portato al “Trump National Golf Club” ed entrai da una porta laterale, aspettando 20 minuti prima di essere introdotto in una modesta “sala conferenze”.
Fui presentato al Presidente, al suo Vice, al Capo dello Staff della Casa Bianca e a pochi altri ancora.
Parlammo della situazione dei nostri militari, con le nostre opinioni che a volte convergevano ed altre volte invece no. L’intervento di Trump durò 40 minuti e fu di ampio respiro — anche il tono fu piacevole.
Successivamente, assieme al Presidente, andammo giù per la scalinata della Clubhouse, dove era riunita la stampa.
Lungo il tragitto pensavo che sarei tornato alla Hoover Institution, Stanford University, dove avevo trascorso gli ultimi anni a fare ricerche.
Pensavo anche che il mio forte sostegno alla NATO, e la disapprovazione all’uso della tortura sui prigionieri, avrebbero portato il Presidente a cercare un altro candidato.
In piedi, accanto a lui, mentre i fotografi scattavano foto, fui sorpreso per la seconda volta quando il Presidente dichiarò ai giornalisti che io ero “la persona giusta”. Alcuni giorni dopo fui ufficialmente nominato.
In precedenza, il sig. Trump mi aveva chiesto se potevo accettare l’incarico. Risposi che avrei potuto, ma che non avevo mai aspirato a diventare il Segretario alla Difesa ed approfittai dell’occasione per suggerire altri possibili candidati che ritenevo altamente capaci.
Tuttavia, cresciuto da genitori che avevano prestato servizio nella 2a GM e plasmato successivamente da più di quattro decenni nel Corpo dei Marines, lo avrei comunque considerato un onore e un dovere.
Se il Presidente ti chiede di fare qualcosa non giochi a rimpiattino torcendoti le mani. Per citare lo slogan di una grande azienda americana, “lo fai e basta”. Se sei sufficientemente preparato per il compito, rispondi di sì.
Quando si tratta di difendere la nostra democrazia e il nostro modo di vivere l’ideologia passa in secondo piano. Se ti viene chiesto di servire il tuo paese non è importante che te lo chieda un democratico o un repubblicano, servi e basta.
Sono stato plasmato da questa etica e non avevo alcuna intenzione di tradirla, nonostante mi stessi godendo la vita a ovest delle Montagne Rocciose, passando il tempo con la mia famiglia, che avevo trascurato per essere stato oltre 40 anni nei Marines.
Quando accettai l’incarico sapevo di essere preparato. Conoscevo quel lavoro fin nei minimi dettagli.
Alla fine degli anni ’90 ero stato Segretario Esecutivo di due Segretari alla Difesa, William Perry e William Cohen. Avevo acquisito una conoscenza diretta dell’immensità e della gravità delle responsabilità di un “secdef”.
Il lavoro è molto duro. Il nostro primo Segretario alla Difesa, James Forrestal, arrivò a suicidarsi e ben pochi, davvero, sono emersi dal quel lavoro del tutto incolumi, legalmente o politicamente.
A suo tempo, avevo inviato un sufficiente numero di lettere ai parenti delle vittime per capire quali sono le conseguenze della guida di un Dipartimento “sul piede di guerra”.
A livello personale non avevo una grande voglia di tornare a Washington DC. Non attingevo energia dal caos e dalla politica che animano la nostra capitale.
Tuttavia, non mi sentivo sopraffatto dall’enormità del lavoro — ero anche convinto di poter ottenere un sostegno bipartisan, nonostante il fratricidio politico praticato a Washington.
La mia carriera nei Marines mi aveva preparato a dire di sì a un lavoro di tale portata.
I Marines ti insegnano soprattutto come adattarti, improvvisare e superare gli ostacoli – ma si aspettano al contempo che tu abbia fatto i compiti, che padroneggi la tua professione.
Le prestazioni amatoriali sono un anatema. I Marines sono molto duri verso sé stessi se non sono all’altezza del loro ruolo.
Eppure, nel corso della mia carriera, nonostante abbia fatto degli errori — e ne ho fatti molti — i Marines mi hanno sempre promosso.
Hanno riconosciuto, in altre parole, che quegli errori erano un passaggio necessario per imparare a fare le cose nel modo giusto.
Sotto un aspetto esterno “prussiano” — capelli corti, uniformi stirate e standard rigorosi — il Corpo ha nutrito alcuni dei personaggi più strani, e alcuni dei pensatori più originali, che io abbia mai incontrato attraverso molteplici Comandi in dozzine di paesi.
L’eccellenza militare dei Marines non soffoca la libertà intellettuale. Conoscono la loro dottrina, appresa in combattimento e scritta nel sangue, ma rifiutano che si trasformi in un dogma.
Guai a chi è privo di fantasia e che, nelle riunioni post-combattimento, si rifugia nella dottrina. Le critiche sul campo, in classe o nell’happy hour, sono franche e schiette. Le due qualità che mi hanno insegnato a valorizzare maggiormente sono l’iniziativa e la determinazione.
Mentre mi preparavo alle audizioni del Senato, lessi molti eccellenti rapporti d’Intelligence. Fui colpito dal grado di erosione del nostro vantaggio militare, compreso quello tecnologico.
Pensai che avremmo dovuto concentrarci sul recupero di questi vantaggi.
Mentre combattevo contro il terrorismo in Medio Oriente, e nei tre anni successivi alla fine del mio servizio attivo, finanziamenti mal indirizzati avevano significativamente peggiorato la situazione, facendo più danni di qualsiasi nemico sul campo.
In quel momento fu per me ancora più chiaro la ragione per cui i Marines assegnano un elenco di letture di ampio respiro a tutti i promossi di grado. Quelle letture forniscono profondità storica ed illuminano il cammino.
Libri come “Le Memorie personali” di Ulisse S. Grant, “Sherman” di B.H. Liddle Hart, “Defeat Into Victory” di William Slim dimostrano che possiamo sempre sviluppare delle nuove idee, indipendentemente da quanto preoccupante sia la situazione.
Il destino, la provvidenza o gli incarichi casuali della mia carriera militare mi avevano sempre trovato pronto. Senza arroganza e con umiltà, avrei potuto rispondere “sì” se mi fosse stato chiesto di servire ancora una volta il mio paese.
Un ammonimento spesso pronunciato nei Marines è questo: “quando vai ad uno scontro a fuoco, porta con te tutti i tuoi amici”.
Avendo spesso combattuto all’interno di una coalizione, sono convinto che abbiamo bisogno di ogni alleato che possiamo portare con noi.
Dalle soluzioni militari al voto presso le Nazioni Unite, più alleati abbiamo e meglio è. C’è sempre spazio per coloro che vogliono essere al nostro fianco.
I paesi con molti alleati prosperano, quelli senza appassiscono. Da sola, l’America non può proteggere il suo popolo e la sua economia.
In questo momento vediamo all’orizzonte nuvole di tempesta. Un leader deve mostrare acume strategico e rispetto per quei paesi che sono sempre rimasti con noi quando ci sono stati problemi.
Tornando a fare causa comune possiamo affrontare meglio il mondo imperfetto che occupiamo insieme.
Non mi era mai venuto in mente che avrei servito di nuovo in un Governo, dopo essermi ritirato dal servizio attivo.
Ma arrivò quella telefonata e un sabato mattina di fine 2017 entrai nella segreteria della Difesa, dopo averlo varcato per la prima volta, come Colonnello, 20 anni prima.
Usando tutto quello che avevo appreso nei miei decenni da Marine, ho sempre fatto il meglio che potevo.
In questo momento ciò che mi preoccupa di più, come militare, non sono gli avversari esterni, ma le nostre divisioni interne.
Ci stiamo dividendo in tribù ostili che tifano l’una contro l’altra, alimentate dal disprezzo reciproco, invece di riscoprire il terreno comune e trovare soluzioni mettendo a rischio, in questo modo, il nostro futuro
Tutti gli americani devono riconoscere che la nostra democrazia è un esperimento e che, come tale, non è irreversibile. Non dobbiamo permettere al tribalismo di distruggerla.
Nel 2010, alla fine della battaglia di Marjah, in Afghanistan, incontrai un marine e un altro soldato, entrambi bagnati fradici, che si erano appena rinfrescati nel vicino fosso d’irrigazione.
Come al solito, dissi loro: “Come va, ragazzi?”. “E’ come vivere un sogno, signore!”, urlò il Marine. “Nessun problema”, aggiunse il secondo con un sorriso.
La loro disinvoltura e il loro buon umore, anche se vivevano alla giornata e in condizioni difficili, mi ricordarono quanto siano irrilevanti molte delle questioni che ci dividono.
Su ciascuna delle nostre monete è inciso il motto americano, “E Pluribus Unum”. Ovvero, “Da Molti, Uno”. Perché il nostro esperimento di democrazia sopravviva, dobbiamo vivere quel motto fino in fondo.
—————–
Link originale: https://www.wsj.com/articles/jim-mattis-duty-democracy-and-the-threat-of-tribalism-11566984601
Scelto e tradotto da Jean Gabin
*****
Le immagini, i tweet e i filmati (i contenuti) pubblicati nel sito sono tratti da Internet per cui riteniamo, in buona fede, che siano di pubblico dominio e quindi immediatamente utilizzabili. In caso contrario, sarà sufficiente contattarci all’indirizzo info@mittdolcino.com perché vengano immediatamente rimossi. Le opinioni espresse negli articoli rappresentano la volontà e il pensiero degli autori, non necessariamente quelle del sito.