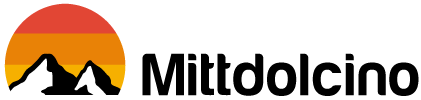Alessandro Staderini Busa per l’Intellettuale Dissidente
Partì tutto da una città di mare, snodo portuale per l’approvvigionamento del paese, perno di produzione, libero ingresso per nuovi sussulti dell’anima.
Le città di mare/ ed ogni favola può essere vera – dice una canzone.
Era un giorno d’estate del 1980 quando, al momento convenuto, ogni operaio mollò il suo posto, uscì sul piazzale sotto il sole delle 15, e tutti insieme si rinchiusero dietro la cancellata dei cantieri navali “Lenin”.
Chiedevano un aumento di salari e sussidi, ed anche un monumento commemorativo per i quarantadue colleghi caduti durante le repressioni di dieci anni prima. La scintilla era stata il licenziamento dell’attivista Anna W., come a dire che il tempo di abbassare il capo ormai era concluso e, da quel momento in poi, un torto fatto ad uno di loro valeva la reazione dell’intero stabilimento.
Perciò si sarebbero scelti il nome di Solidarność, una delle poche parole polacche simile al corrispettivo italiano (solidarietà). Nessuno sa ben dire quanto dovettero sobbalzare di risa le poltrone del potere alla notizia di quel nucleo di scioperanti che si illudevano di far la voce grossa col regime.
Anche perché un capo non lo avevano ancora. E quello scelto più tardi dall’inizio dello sciopero, l’elettricista coi baffi a ferro di cavallo Lech Walesa, pareva più il tipo di rustico avventore da bar che il sindacalista di professione.
Chi avrebbe scommesso su quella stravagante forma di protesta che, evitando il faccia a faccia della manifestazione di piazza, optava, secondo consiglio di Thoreau, per la resistenza non violenta?
Questa la strada che abbiamo scelto – dicevano – la difesa dei nostri diritti e della nostra dignità, così come gli sforzi di non permettere mai a noi stessi di essere sopraffatti dal sentimento di odio.
Eppure, a fronte dell’inizio un po’ a tarallucci e vino – o meglio, a vodka e aringhe – bastarono tre giorni perché nel resto del paese si raccogliesse il messaggio lanciato sul fronte del porto di Danzica.
Ovunque, altri operai si fecero coraggio, iniziando a chiudersi dentro le fabbriche, e i loro delegati raggiunsero il centro della protesta nazionale, dove prese forma un Comitato di sciopero sempre più convinto di poter far valere le proprie pretese.
Così, mentre nel privato delle case le donne iniziavano una cordata di preghiera h 24, a imitazione della “rosenkranz-sühnekreuzzug” con cui gli austriaci del dopoguerra avevano rimandato al mittente i sovietici, gli scioperanti salirono a qualche milione.
Con ben 21 richieste vergate su una targa di legno sopra l’ingresso dei cantieri navali, si voleva la democratizzazione della società e una vita migliore per i loro figli.

Al governo, fantoccio della sovrastruttura dei Soviet, veniva dato, come termine per accettare, l’ultimo del mese.
Non erano nuovi, i polacchi, a simili exploit, audaci al limite del cafone, come quando provavano a chiedere la resa dei nazisti in quel di Varsavia, di fatto andando al massacro.
Stavolta, però, gli eredi di quel Sobieski vittorioso sugli Ottomani si ergevano, al cospetto del tiranno di turno, senza armi e con serrata compattezza, tali che le poltrone del potere, spavalde per natura, iniziavano a farsi piccole dall’apprensione.
Inattuabile, infatti, il ripulisti manu militari che le autorità chiedevano all’URSS su modello dell’Ungheria e della Cecoslovacchia ’56 e ’68. I russi si erano appena impelagati sul fronte afgano, il governo era lasciato spalle al muro, con un risveglio di popolo che montava come una marea.
La fonte unica e basilare della nostra forza è la solidarietà dei lavoratori, dei contadini, degli intellettuali – avrebbe dichiarato il futuro capo dello Stato, Walesa – la solidarietà della nazione, la solidarietà di persone che cercano di vivere con dignità, veramente.
La rivoluzione senza spargimenti di sangue ripagava l’arditezza di chi ci aveva scommesso.
Ed il suo successo veniva ratificato in quell’incontro fra le parti passato alla storia come “Accordi di Danzica”, da cui un Walesa con sorriso a trentadue denti usciva portato in trionfo da un esercito in tuta blu da operaio.
Il più rigoroso degli Stati satelliti comunisti accettava tutte le richieste e, riconoscendo in Solidarność un sindacato indipendente ed autogestito, metteva in scena, volente o nolente, l’atto primo di una celerissima frana che avrebbe portato giù la cortina di ferro su mezza Europa. Inutile e transitoria la legge marziale del generale Jaruzelski, quando il sindacato emblema di libertà veniva messo al bando e si apriva la stagione delle persecuzioni ai capi del movimento. Il conto alla rovescia era partito, con la Storia ad aver ormai scelto la più insperata delle soluzioni.
Diceva bene de La Boétie, convinto che non c’è bisogno di combattere il tiranno, né di toglierlo di mezzo; si sconfigge da solo, a patto che il popolo non acconsenta alla propria servitù.
Come dunque non riconoscere, in questi giorni di ottobre, il “filo rosso del destino” – per dirlo con la tradizione giapponese – che lega il dito della cattolica Polonia a quello del nostro Paese, prescelto laboratorio di sperimentazione delle misure draconiane (ovvero dragoniane) propedeutiche al plurisbandierato Great Reset?
Come non sentire in quelle parole del premier Morawiecki alla von der Leyen, nell’aula della plenaria del Parlamento europeo – “Non ci facciamo ricattare dall’UE, abbiamo combattuto il Terzo Reich” – i palpiti di ogni Davide che ha di fronte un Golia?
Come non guardare alla piccola Trieste come a una Danzica 2.0, e al portabandiera dei dimostranti, il facchino in tuta gialla Stefano Puzzer, la versione italica dell’elettricista Lech Walesa?
Poiché, nel primo e nel secondo caso, nell’uno e nell’altro porto, in ballo era e resta il medesimo valore. Una battaglia per la libertà, per la democrazia, per tutti noi e per i nostri figli.
Quelli che dal 15 del mese sono scesi a scioperare sui moli, sgomberati a getto d’idranti e non piegati nella loro rimostranza, sono parsi sin dall’inizio ribadire l’ovvio.
Un ovvio che, oltre all’aspetto manuale e virile delle loro mansioni, accumuna i portuali di oggi agli operai di ieri, come a ogni contestatore delle leggi inique dell’uomo.
Un ovvio che equivale ai diritti di libertà personale con cui, in ogni tempo e luogo, nasce ciascun individuo. Libertà ancora più limpida e naturale, nell’odierno mondo libero, da campeggiare, nero su bianco, nell’art. 32 di una Costituzione italiana redatta quale risanamento alle ferite di una dittatura.
L’inglese Chesterton li aveva predetti meglio d’un oracolo i tempi in cui fuochi verranno attizzati per testimoniare che due più due fa quattro. Spade saranno sguainate per dimostrare che le foglie sono verdi in estate. Noi ci ritroveremo a difendere non solo le incredibili virtù e l’incredibile sensatezza della vita umana, ma qualcosa di ancora più incredibile, questo immenso, impossibile universo che ci fissa in volto.
Ebbene, salvo equivoci, quei tempi sono i nostri e lo scoglio che i portuali pongono sulla via della più aggiornata forma di dittatura d’Occidente è questione che riguarda tutti.
Togliere il decreto del green pass e togliere l’obbligatorietà del vaccino. Questo è il nostro obbiettivo finale e non ci fermeremo finché questo non accadrà — ribadisce Puzzer, ogn’ora più svociato per il lungo parlare e per le notti all’addiaccio su piazza Unità d’Italia, centrale del dissenso che solo una rediviva propaganda soviet style, oscurate le telecamere per non mostrare ai tg la partecipazione di massa, imputa all’indipendentismo della città di mare.
La cosa più forte che sta succedendo è che tantissime persone che hanno il green pass e sono vaccinate, si stanno unendo a chi non ce l’ha e a chi protesta per questo strumento – commentava il direttore de “L’Espresso”.
L’altro giorno, difatti, di presenze se ne contavano 15 mila, il che non è poco se i triestini ammontano complessivamente a 200 mila anime.
I portuali di Genova hanno unito le forze e una delegazione ha raggiunto Trieste, ad attendere insieme il 30 ottobre, termine ultimo perché il governo faccia un passo indietro e si torni al lavoro come finora era sempre stato.
Le piazze di Bolzano, Milano, Roma, Bergamo, Palermo, Pavia e non solo, si uniscono ogni sera, virtualmente, accendendosi come torce nel buio, con sveltezza pari a quella con cui si risvegliava, fabbrica dopo fabbrica, paesello dopo paesello, la Polonia del 1980.
In tutte si prega, una cosa che non si vedeva in giro da parecchio. E non si prega solo lì, ma pure sui gruppi Telegram spuntati come funghi per ovviare a chi non può uscire di casa e unirsi fisicamente.
Ciò che infatti sorprende più, è l’entrata in ballo della religiosità in manifestazioni a carattere laico. Effigi della Vergine e di Michele Arcangelo, corone del rosario e icone di San Giorgio, le stesse che le foto d’epoca testimoniano appese ai cancelli dei cantieri di Danzica.
Siano esse esibite superstiziosamente o per vero credo, dimostrano la consapevolezza che la gente schierata oggi ha di trovarsi davanti a qualcosa di ben più subdolo dell’attuale dirigenza italiana.
Casta che, da un verso politico all’altro, mostra negli sguardi, nelle scelte, nelle ispirazioni, oramai quasi più nulla che sia di umano.
Né può mancare la benedizione di un alto prelato, necessaria per ogni crociata contro forze preponderanti, a maggior ragione trattandosi qui di tener testa al Drago, come Bilbo Baggins fece con Smaug a Erebor.
Ma se il Giovanni Paolo II del Non abbiate paura! pompava, a getto continuato, coraggio, ideali, sostegno economico, ai compatrioti polacchi, lo stesso non possiamo dire per il corrispettivo del nostro infausto capitolo storico.
Francesco appare sempre più orientato verso un populismo di gesti ma non di fatti, a farsi sponsor della causa di un’élite globalista via via più invasiva, anziché scendere a protezione di quel gregge la cui cura gli competerebbe per dovere.
Ai suoi “edificando un Nuovo Ordine Mondiale, tutti insieme potremo risanare le ingiustizie” e “serve Big Reset delle regole per una nuova governance” ribatte, per fortuna, l’arcivescovo Carlo Maria Viganò, da location segreta in cui per ovvi motivi si nasconde.
Sola voce a distinguere, nel caos, le fogge oscure di un potere politico e sovrapolitico, il quale, nelle direzioni in cui muove il mondo, non cerca il bene collettivo, quanto il proprio tornaconto e la propria onnipotenza. Intenso l’ultimo discorso recapitato, notti fa, ai portuali sulla piazza, una sintesi emozionale, un’analisi degli ultimi due anni passati in preda alle paure.
Parole da buon pastore, che chiamano a sostegno delle pecore in balìa dei lupi, il conforto di assistenza soprannaturale.
Chiediamo alla Madonna di soccorrere la nostra Italia, di proteggerla, di liberarla. Pregate con fede e sarà lei a sbaragliare e sconfiggere inesorabilmente il nostro avversario.
Ma niente male neppure la replica fuor di metafora del portabandiera dei portuali. Non molliamo, perché se molliamo noi, qui son cazzi per tutti.
E chissà se un giorno non si vedrà Puzzer alla Presidenza della Repubblica, come accadde con Walesa, a patto che i portuali vincano il braccio di ferro come riuscì a quelli di Danzica.
Le città di mare/ ed ogni favola può essere vera … cantavano i fratelli Bennato, in un disco uscito l’anno che crollò il muro di Berlino.
*****
https://www.lintellettualedissidente.it/controcultura/societa/trieste-danzica-green-pass/
Scelto e pubblicato da Franco