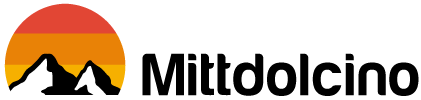Chissà se i primi ominini hanno provato vergogna e colpa. E poi per quale primordiale ragione? E chissà quale delle due è sorta in loro per prima o ha prevalso nell’ancestrale sentire biologico della breve “storia umana”: ammesso che si possa parlare di prevalenza dell’una sull’altra e non di avvicendamento tra le due.
Una cosa però pare certa. Quando si scruta la vergogna si ha bisogno dello sguardo dell’altro. La vergogna ha infatti ben poco a che fare con l’individualità e con la risonanza biologica delle emozioni profonde. La vergogna non è paura, né rabbia, né odio.
A partire dai primi anni di vita ogni bimbo comincia a percepire il giudizio degli altri. Egli non si può sentire in colpa ma adombra segnali di reazione allo sguardo di chi è stato gettato in vita prima di lui e dalle cui cure dipende la sua stessa esistenza: così il bimbo esce dalla dimensione innocente della propria “follia” ed inizia a percepire che per gli altri esiste un modo corretto ed uno sbagliato di stare al mondo.
È dunque questo il primo segnale di percezione dell’inadeguatezza per ogni essere umano o, se vogliamo, di vergogna?
Forse sì. Anzi, sì.
Non pare quindi un caso che la parola vergogna provenga dal latino “verecŭndia”, quale espressione che indica un disagio reverenziale e timoroso per la possibile condanna sociale che segue al giudizio di inadeguatezza al codice comportamentale imposto in un certo momento storico da una qualsiasi aggregazione umana.
La “verecŭndia”, per poter emergere ed essere provata, ha bisogno della relazione sociale. Essa invero nasce nelle relazioni e scaturisce dall’identità personale, accostandosi alla stessa anche al di là della vita dell’individuo.
La vergogna è perciò fortemente identitaria poiché l’identità personale necessita del riconoscimento che proviene dagli altri: sono in verità gli altri, in mezzo ai quali ogni uomo nasce, vive e muore, ad attribuire l’identità individuale.
E sono gli altri ad accompagnare ogni vita umana in una metodica liturgia di variegati riconoscimenti che muovono dall’attribuzione di un nome sino a giungere alla condanna ad una pena severa.
Anche la condanna alla pena di morte è una forma radicale di riconoscimento sociale che impone e prevede l’estremo giudizio di inadeguatezza di un uomo a far proprio e rispettare un codice relazionale.
Quando invece si parla di colpa è indispensabile “scavare” più a fondo. Si deve fare pulizia di antiche incrostazioni: per parlare di colpa pare infatti essenziale allontanarsi dai codici sociali, giuridici e, soprattutto, da quelli religiosi. Per indagare l’essenza della vera colpa sembra in realtà necessario allontanarsi da tutte le possibili forme assunte dai codici relazionali.
Prima di ragionare intorno alla “cŭlpa” bisognerebbe pure tentare di liberarsi dai condizionamenti delle categorie giudaico cristiane che, da oltre duemila anni, impregnano sapientemente la psiche collettiva occidentale: quella di tutti gli occidentali. Non importa se di persone credenti oppure no poiché la religione, prima ancora di essere fede, è filosofia, è pensiero e, quindi, da psiche è divenuta stile e metodo di vita andando ben oltre la ristretta cerchia di chi si professa credente.
Incrementiamo l’intensità della luce a proposito del significato profondo di colpa.
La colpa è l’espressione biologica più potente della volontà di vita e, se guardata come tale, si capirà che essa si tiene lontana dalle categorie e dai coefficienti sui quali si fondano le relazioni umane organizzate.
La colpa, infatti, svela la propria antitesi con il “noi”. Essa è la forma di sofferenza più profonda che si prova al cospetto dell’impossibilità di vita. Si presenta quando è frustrata la volontà di potenza biologica che caratterizza tutti gli esseri viventi: la volontà di vita.
La colpa è innata perché fortemente biologica e, seppur dettata dalla legge della specie – la legge naturale che impone ad ogni madre di sacrificare sé stessa limitando il proprio spazio vitale in favore della prole e, dunque, della specie –, rimane una faccenda confinata dal vitale sentire umano: quello esclusivamente individuale. È una reazione quasi carnale prima ancora di essere risonanza sentimentale che lega la madre al figlio e il padre a madre e figlio.
In questa relazione istintiva di base, accesa e spinta dalla legge della specie, dalla sofferenza di chi cerca la vita e dall’impotenza che si prova nel non poterla espandere, non c’è spazio per la vergogna, poiché la colpa è una tragica ed intima faccenda non inscrivibile nel sociale.
Una madre che non riesce a far vivere il figlio si dispera tragicamente al netto di ogni considerazione che riguardi il proprio io o l’immagine di donna che si proietti all’esterno della propria frustrazione. L’impossibilità di crescere un bimbo è in primo luogo una sconfitta per la specie anche se le più atroci sensazioni di colpa che ne seguono sono della madre.
Sicché, tutte le forme di colpa che si discostino da questa rigida risposta biologica di base, dovrebbero essere assunte nel ben diverso paradigma della vergogna poiché le stesse non potrebbero essere parte del sentire profondo, innato, intimo e distruttivo della colpa, quella vera che nulla ha a che fare con gli altri e men che mai con i codici o i mutevoli coefficienti dettati dall’esigenze di imporre o mantenere un certo ordine di relazioni tra individui aggregati.
La colpa e la vergogna sono inconciliabili tra loro e sarebbero da tenere ben distinte. Solo la prima è ineliminabile poiché dettata dalla stessa volontà di potenza intesa quale volontà di vita. E solo alla seconda pochi uomini possono completamente sottrarsi, facendone totalmente a meno anche quando la impongo rigidamente ai molti.
La vergogna, a dispetto della colpa, non è affatto per tutti. Non è mai stata per tutti.
Sono forse due le categorie di persone che paiono andare esenti dal provare o dal dover rispondere alle regole della vergogna: essi sono i frequentatori della follia e gli ultimi uomini potenti o che si trovano in posizioni di potere. I primi sfuggono dall’essere imprigionati dai codici della vergogna perché ne rimangono innocentemente al di fuori; i secondi possono starne al di sopra in falso nome della sicurezza di tutti coloro che costringono all’osservanza di norme sociali create ed imposte dalle occasioni che radicano il potere di cui dispongono. E gli esempi concreti realizzati da coloro che appartengono alla menzionata seconda categoria sono molti: talvolta sono eclatanti, talaltra appaiono offuscati.
La guerra è da sempre il mezzo eclatante che genera le più inestricabili mischie tra differenti vergogne sociali che non sono reciprocamente comprensibili da chi la combatte. Nella mischia della guerra nessuno ha vergogna, né potrebbe più avere comprensione per le vergogne degli altri. La germanica espressione “werran”, da cui deriva la parola guerra, significa appunto mischia. E nella mischia non si può avere rispetto degli altri, non sarebbe una reazione fisiologica possibile.
Non c’è dunque alcuna vergogna nel dichiarare o nell’imporre agli altri di resistere ad una guerra. E questo poiché il codice regolatorio che viene in entrambi i casi drammaticamente violato non è quello predicato al gruppo sociale che sta sotto a coloro che hanno deciso di imporlo, forzando la partecipazione di tutti alla mischia generata dalla guerra che i pochi hanno voluto. Ogni individuo di potere si piazza al di sopra del codice che impone, al contempo considerando inesistente o inaccettabile quello del proprio nemico poiché, in primo luogo, non è lui ad averlo voluto.
E chi è al di sopra delle regole della vergogna, quali essenza dei codici sociali, dispone anche di mezzi per allontanare da sé la risonanza bruciante di ogni possibile vera sensazione di colpa: quella profonda e straziante di chi perde un figlio senza nemmeno poterne evitare la morte. Vera colpa che non esplode nell’animo degli uomini di potere, nemmeno quando una guerra stronca le vite dei giovani figli degli altri, ossia di coloro che hanno obbedito ai codici sociali imposti dall’alto per non provare la vergogna che i loro leader non conoscono e che, almeno per le guerre dagli stessi provocate, iniziate, avallate o resistite, non proveranno mai.
Lorenzo TAMOS
Lorenzo TAMOS (lorenzo.tamos@avvocatinteam.com) – avvocato del Foro milanese; commentatore, scrittore e saggista; patrocinatore presso le giurisdizioni nazionali superiori e internazionali; esperto nella materia del diritto delle nuove tecnologie, della comunicazione on line e delle piattaforme digitali; esperto della materia del trattamento dei dati personali, nonché della regolamentazione e uso dell’intelligenza artificiali; avvocato amministrativista e del diritto pubblico dell’economia; DPO di realtà pubbliche e private d’eccellenza sia nazionali che internazionali; presidente di importi organismi di vigilanza ex Dlgs n. 231/2001 nel settore socio sanitario para pubblico; ex ufficiale della Guardia di Finanza e componente di comitati scientifici di associazioni nazionali di polizia e della sicurezza urbana partecipata.